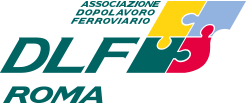06 4418 0210
segreteria@dlfroma.it
Quando la sera tornavano dai campi
Sette figli ed otto col padre
Il suo sorriso attendeva sull’uscio
per annunciare che il desco era pronto.
Ma quando in un unico sparo
caddero in sette dinanzi a quel muro
la madre disse
non vi rimprovero o figli
d’avermi dato tanto dolore
l’avete fatto per un’idea
perché mai più nel mondo altre madri
debban soffrire la stessa mia pena.
Ma che ci faccio qui sulla soglia
se più la sera non tornerete.
Il padre è forte e rincuora i nipoti
Dopo un raccolto ne viene un altro
ma io sono soltanto una mamma
o figli cari
vengo con voi.

Il 28 dicembre di settantacinque anni fa, in un’alba nebbiosa, al poligono di Reggio Emilia, gli spari dell’esecuzione che uccise i sette fratelli Cervi più l’ex repubblichino convertito all’antifascismo Quarto Camurri, segnarono l’esordio stragista della neonata Repubblica di Salò, regime fantoccio al servizio della Germania nazista.
Furono per prime le stesse gerarchie repubblichine a rendersi conto dell’abominevole gesto preoccupate di aver rivelato il volto truce del fascismo morente. Ma è forse la paura di una Resistenza palese e organizzata come quella dei Cervi a indurre all’eliminazione di un pericolo che nelle campagne della Bassa tra Campegine e Gattatico era diventato minaccioso.
I Cervi, famiglia di solide basi cattoliche (il papà Alcide fu iscritto al partito popolare e subì l’influenza di Camillo Prampolini nelle campagne emiliane), era antifascista fin dagli anni ’30, quelli del massimo consenso al Mussolini trionfante dell’impresa coloniale. Il 25 luglio del ’43, alla caduta del Duce, offrirono la pastasciutta a tutto il paese e dopo l’armistizio dell’otto settembre, presero le armi cominciando a organizzare la Resistenza tra l’Appennino e la pianura dove si stavano formando i primi gruppi “Gap” (Gruppi D’Azione Patriottica) con modalità di guerriglia e spionaggio.
Determinante per la scelta è il terzogenito Aldo, già impegnato nell’Azione cattolica, ma presto convinto alla fede comunista dal rapporto con Lucia e Otello Sarzi, che assieme formavano una compagnia di attori itinerante presto divenuta un’agenzia di propaganda antifascista.
Aldo compatta la famiglia attorno all’ideale rivoluzionario. Con lui ci sono i fratelli Gelindo, Antenore, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. I nomi di questi ultimi sono forse un omaggio alle letture della mamma Genoveffa Cocconi, donna capace di comunicare l’amore per la conoscenza ai nove figli (ci sono anche le sorelle Diomira e Rina).
I Cervi sono contadini autodidatti per i quali la cultura e la conoscenza si traducevano anche nello sperimentare tecniche nuove di coltivazione nel podere dei “Campirossi”. Furono i primi a usare il trattore, “la macchina del futuro” come lo chiamavano, e a introdurre una gestione innovativa della stalla. Pionieri, insomma. Anche in politica. Assieme a Didimo Ferrari fondano una biblioteca popolare per stimolare i contadini a emanciparsi e si oppongono all’ammasso imposto dal fascismo ai prodotti della campagna. Il loro attivismo li porta ad esporsi troppo.
Lo stesso guardingo partito comunista reggiano, già organizzato clandestinamente e militarmente, non approva quella che giudica una fuga in avanti resistenziale dei Cervi.
Di fatto la famiglia resta isolata ed è forse per questo che diventa un bersaglio relativamente facile per i fascisti. Il podere dei “Campirossi” è nell’inverno ’43, una mèta di oppositori al regime, di soldati sfuggiti al giogo tedesco e renitenti alla leva di Salò, nonché di militari stranieri fuggiti dalla prigionia. Un rischio troppo grosso nel cuore dell’Emilia “rossa” al punto che col pretesto di vendicare l’attentato mortale al gerarca repubblichino Davide Onfiani a Bagnolo, altro centro della Bassa reggiana, il 25 novembre, un battaglione fascista circonda la casa dei “Campirossi”, incendia stalla e fienile e pone l’assedio.
Dalle finestre i Cervi tentano una inutile difesa. In casa ci sono cinque donne e dieci bambini, al piano superiore, oltre ai sette fratelli e a Camurri, sono asserragliati Dante Castellucci, il futuro comandante partigiano “Facio”, il russo Anatolij Tarassov e tre soldati alleati: i sudafricani John David Bastiranse (Basti) e John Peter De Freitas (Jeppy) più l’irlandese Samuel Boone Conley.
Gli stranieri sono trattati da prigionieri di guerra, compreso Castellucci che conoscendo il francese si spaccia per tale e fuggirà in seguito dalla fortezza parmense della Cittadella unendosi ai partigiani d’Appennino.
Per i Cervi e Camurri c’è il carcere duro di San Tommaso a Reggio Emilia. A loro carico ci sono azioni partigiane come l’assalto a una caserma sui monti reggiani di Toano, il disarmo dei carabinieri a San Martino in Rio e un fallito attentato al segretario del partito fascista locale Giuseppe Scolari. A poco più di tre mesi dall’otto settembre, la vicenda dei Cervi si conclude con gli spari dei moschetti repubblichini.
L’ultimo atto di crudeltà dei gerarchi è impedire l’estremo congedo del papà Alcide ai suoi figli prima dell’esecuzione. Il fascismo pensava così di annientare un nemico mortale nel cuore di un Emilia che diventerà luogo di frontiera lungo la linea Gotica. In realtà faceva sì che si costituisse un simbolo attorno al quale si coagulerà più forte la Resistenza non solo reggiana contro la dittatura e l’occupazione tedesca.

Nacque a Firenze il 21 apr. 1889 da Rodolfo e Laudomia Pimpinelli. La sua educazione si svolse quieta e severa, in un ambiente in cui le idealità mazziniane del padre, professore di diritto commerciale e deputato repubblicano dal 1906 al 1908, non solo contribuirono alla formazione di un rigoroso costume morale, ma sollecitarono probabilmente quella inclinazione alla “bontà” che quanti lo avvicinarono hanno sempre voluto mettere in evidenza. E i primi scritti del Calamandrei sono di letteratura infantile, versi e favole pubblicati tra il 1910 e il 1912 su Il giornalino della domenica, il Corriere dei piccoli, Primavera, e più tardi raccolti in due volumi, La burla di primavera(Firenze 1920), I poemetti della bontà (ibid. 1925).
Il tempo degli “svaghi poetici” passò presto. Seguendo la tradizione familiare, il giovane Calamandrei intraprese gli studi giuridici e vi si dedicò con impegno esclusivo nell’università di Pisa, sotto la guida di Carlo Lessona, con il quale discusse nel 1912 una tesi di laurea sulla chiamata in garanzia. Questo sarà il tema dei suoi primi lavori giuridici: una nota, pubblicata nel 1912 su Il Foro italiano, dal titolo Chiamata in garantia e giurisdizione arbitrale;e il volume La chiamata in garantia (Milano 1913), un’opera di grande impegno e serietà, ma abbastanza lontana dai caratteri che saranno ben presto tipici del lavoro scientifico del Calamandrei. In quegli anni, infatti, matura la svolta determinante per tutta la successiva attività dello studioso. Recatosi a Roma per perfezionarsi negli studi di diritto processuale civile sotto la guida di G. Chiovenda, che già aveva intrapreso la sua grande opera di rifondazione scientifica di quella disciplina, il C. fu ben presto conquistato dall’insegnamento del maestro, di cui, da allora in poi, volle professarsi e fu discepolo. I segni del nuovo orientamento sono ben presto evidenti nell’importante saggio su La genesi logica della sentenza civile (Firenze 1914). E, l’anno successivo, il Calamandrei divenne professore titolare della cattedra di diritto processuale civile nell’università di Messina.
Sopravvenuta la guerra, si arruolò volontario, da null’altro spinto che da un generico interventismo. Negli anni del conflitto, tuttavia, cominciarono a manifestarsi concretamente quegli atteggiamenti che avrebbero più tardi dato il tono alla sua attività pubblica. Egli, infatti, non fu soltanto il valoroso combattente, che aveva iniziato il conflitto con il grado di sottotenente e l’aveva terminato con il grado di capitano e la decorazione della croce di guerra, uno dei primi soldati italiani a entrare a Trento il 3 novembre 1919: è anche l’ufficiale che, in uno dei tanti terribili processi di guerra, volle prendere le difese di otto soldati accusati di aver abbandonato il loro posto e riuscì ad evitar loro le pesanti conseguenze di quell’accusa.
Dopo la fine della guerra il Calamandrei torna all’insegnamento universitario, passando all’università di Modena nel 1918, e riprende il lavoro scientifico, che darà un frutto tanto significativo con i due volumi su La Cassazione civile (Torino1920). L’opera, monumentale nell’impianto e nello svolgimento, ha un dichiarato fine di politica del diritto: contribuire al superamento del sistema delle cinque corti di cassazione regionali, sostituendo loro una corte unica, capace di vegliare effettivamente sull’uniforme applicazione della legge. Il disegno politico avrà ben presto successo, ed è rivelatore tanto della ispirazione del Calamandrei, quanto delle vie che egli sceglie per concretarla. Appare chiara la sua predilezione per le imprese di riforma, rispetto a quelle di applicazione e commento; così come sono evidenti la costante ricerca di strumenti capaci di assicurare la supremazia ai valori della legalità e della certezza del diritto, la preoccupazione continua di costruire un quadro istituzionale nel quale sia possibile salvaguardare un “diritto perpetuamente in pericolo”.
Nei suoi scritti il diritto processuale civile, una delle tante discipline in cui il trionfante formalismo celebrava ormai i suoi fasti, ritrova i suoi nessi con i problemi reali, le più ardue costruzioni teoriche vengono puntualmente ricondotte alle loro reali matrici ideologiche. Ciò corrisponde al programma scientifico del Calamandrei: “spiegare qual è la funzione utile del diritto nella società”, senza mai ritenere che “le teorie abbiano un valore per sé”: che è, d’altra parte, la via per ritrovare quale sia il reale interlocutore del processualista, cioè il cittadino con i suoi diritti.
In questo quadro deve essere spiegata l’adesione convinta e totale alle teorie chiovendiane, che segnavano una rottura netta con la visione liberale del processo, considerato un luogo dove trovavano realizzazione unicamente i diritti delle parti interessate, alle quali doveva conseguentemente essere riservata la disponibilità assoluta degli strumenti processuali.
Al sistema del codice del 1865, individualista e liberale, Chiovenda tendeva a sostituire “un sistema nettamente orientato su principi pubblicistici e in un certo senso autoritari” (come ha scritto lo stesso C.), con l’attribuzione di larghi poteri al giudice volti anche a realizzare interessi generali. Di questo autoritarismo, implicito nella teoria da lui stesso accolta, il C. era dunque ben consapevole: e tuttavia egli negò sempre che ciò potesse portare a una assimilazione con teoriche radicalmente stataliste, rappresentando la linea chiovendiana piuttosto una terza via tra queste ultime e il sistema liberale. Giustificata o no, che fosse questa interpretazione, è certo che il processo liberale non può essere riguardato come un astratto luogo in cui pacificamente trovavano componimento i conflitti di parti egualmente capaci di utilizzare gli strumenti posti a loro disposizione: la reale disparità di forze dei litiganti, dalla quale da tempo muovevano le critiche socialiste a quel sistema, richiedeva che al giudice fosse attribuita anche una funzione riequilibratrice, proprio nell’interesse di una decisione “giusta”. Alla rottura degli schemi liberali, allora, deve guardarsi proprio come ad un tentativo di porre rimedio ai difetti di un sistema che aveva largamente mostrato di non saper rispondere alle reali domande provenienti dall’organizzazione sociale.
Questa più diretta e convinta attenzione per la “funzione utile” del diritto è ben visibile in tutta Popera del C. e può dar l’impressione, unita com’è con una minore compiacenza per i formalismi, che questa abbia uno spessore teorico minore di quella di altri contemporanei. Senza voler qui discutere che cosa sia buona o cattiva “teoria”, il vero problema è quello del contributo del C. alla scienza del processo civile, una volta accertato il suo operare nel solco tracciato dal Chiovenda. Ma qui vale l’avvertenza data all’inizio: l’essere, cioè, il significato più profondo del lavoro del C. nella sua capacità di arricchire e recuperare a una dimensione culturale un discorso che, altrimenti, rischia di inaridirsi e di perdere ogni senso in ingannevoli labirinti tecnici.
Una volta imboccata questa strada, era quasi naturale che il C. considerasse in modo particolare il ruolo e gli atteggiamenti concreti degli “operatori” processuali, giudici e avvocati, e si avvicinasse alla politica senza aggettivi. I primi segni sono l’incontro, nel 1919, con Gaetano Salvemini e la collaborazione a L’Unità con due articoli; e, nel 1920, la partecipazione alla fondazione del fiorentino Circolo di cultura. Intanto si era sposato con Ada Cocchi, da cui ebbe un figlio, Franco, per il quale egli tornò alla consuetudine degli scritti per l’infanzia, che apparvero tra il 1918 e il 1922 su vari giornali e riviste e vennero poi raccolti nel volume Colloqui con Franco (Firenze 1923). Quest’ultimo appare nelle edizioni della Voce, a cui il C. aveva già affidato nel 1921 la pubblicazione di Troppi avvocati! Lo studio teorico del processo si intreccia così con l’attenzione per i problemi dell’organizzazione professionale degli avvocati e della preparazione giuridica nelle università: in collaborazione con Giorgio Pasquali appare L’università di domani (Foligno 1923), in cui il C. formula appunto tutta una serie di proposte per la riforma delle facoltà di giurisprudenza.
Ma il problema dell’amministrazione della giustizia non è solo nell’organizzazione corporativa e nella preparazione professionale. E il nodo politico viene affrontato con il discorso su Governo e magistratura, letto il 13 novembre 1921 nell’università di Siena, alla quale era passato come professore ordinario nel 1920.
In questo discorso, la denuncia delle indebite ingerenze dell’esecutivo nell’attività giudiziaria è netta e il quadro del reale funzionamento dell’amministrazione della giustizia è assai più rigoroso e convincente di quello che risulta da scritti successivi, assistiti da una vena letteraria e aneddotica fin troppo ricca (primo tra tutti, il celebratissimo Elogio dei giudici scritto da un avvocato, pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1935e poi ampliato e accresciuto fino alla terza edizione del 1955;nello stesso filone sono i “due dialoghi”, pubblicati nel 1941, Delle buone relazioni tra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile).
Il progressivo ampliarsi della sfera di interessi è ben visibile in altri scritti di quegli anni: dal bel saggio sul Significato costituzionale delle giurisdizioni di equità (Modena 1921) all’analisi de Il programma di politica giudiziaria dei socialisti tedeschi, ai due scritti per la Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht sulle Zivil prozess reformen in Italien (1922, 1923).
Sono ormai gli anni del fascismo, che impone agli studiosi “appartati nelle biblioteche” di “alzare la testa dai libri” e di “affacciarsi alle finestre”. La scoperta della politica da parte del C. è ormai completa, e i fatti lo spingono ogni giorno di più in primo piano. Il 31 dic. 1924 il Circolo di cultura e molti studi di avvocati vengono devastati dai fascisti: il C. interviene, protesta, firma manifesti. Assume la difesa di G. Salvemini, è uno dei componenti del consiglio direttivo dell’Unione nazionale di G. Amendola, firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di B. Croce. Dopo il delitto Matteotti aderisce alla società “Italia libera”, ed è in stretti rapporti con il gruppo antifascista fiorentino del Non mollare, al quale appartenevano, tra gli altri, G. Salvemini, E. Rossi, i fratelli Rosselli, N. Traquandi.
Questa breve e intensa stagione politica è presto spenta dal consolidarsi del regime. Si apre così per il C. un lungo periodo tutto dedicato agli studi, all’esercizio dell’avvocatura, all’insegnamento universitario in quell’ateneo fiorentino al quale era giunto nel 1924, collaborando alla sua fondazione. Gli scritti giuridici sono sempre più numerosi: dal 1930 comincia a raccoglierli nei volumi degli Studi sul processo civile, di cui appaiono immediatamente i primi due (Padova 1930) e ai quali seguono il terzo (ibid. 1934) ed il quarto (ibid. 1939); il quinto sarà pubblicato nel 1947 e,il sesto apparirà postumo nel 1957. Ai corsi litografati delle lezioni universitarie si affiancano diversi studi specifici: Il procedimento monitorio nella legislazione italiana (Milano 1926), Linee fondamentali del processo civile inquisitorio (Padova 1927), Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari (Padova 11936); e, nel 1939 (Padova), i due importanti saggi su La relatività del concetto di azione e Il giudice e lo storico.
Riprendono vigore i mai sopiti interessi letterari: al già citato Elogio segue, nel 1941, l’Inventario della casa di campagna (2 ediz. ampliata, Roma 1945), forse la sua opera letteraria più profonda e sorvegliata. A far da ponte, su un crinale dove il diritto si fa pretesto letterario, stanno le esercitazioni eleganti sulla Crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell’America (Padova 1938) e la prefazione a una operetta cinquecentesca di F. Sansovino, L’avvocato e il segretario (1942). Non fu il C. il solo giurista a trovare in quegli anni qualche consolazione in ozi letterari; ma per lui si aprì anche, con la pubblicazione di uno studio su Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini (Roma 1930), un nuovo campo di interessi, che lo portò ad aggiungere alle sue tante facce di studioso anche quella di indagatore celliniano (i vari contributi sono ora raccolti in Scritti e inediti celliniani, Firenze 1971).
Nel settore giuridico, poi, il C. svolse una benemerita opera di organizzatore culturale, fondando nel 1924 la Rivista di diritto processuale civile (di cui sarà prima redattore-capo e poi direttore, insieme con G. Chiovenda e F. Carnelutti), nel 1926 Il Foro toscano (con E. Finzi, S. Lessona, G. Paoli) e nel 1932 la collana di “Studi sul processo civile”, che dirigerà fino al 1942.
Al pari di molti altri giuristi, l’unica attività pubblica del C. fu in quegli anni la partecipazione ai lavori di riforma della codificazione: e può certo dirsi che il suo contributo al nuovo codice di procedura civile del 1942 fu notevole.
Sulle ragioni di questa partecipazione, per lui e per gli altri, si discute ancora con molta cautela. Certamente, per il C. non può valere la spiegazione puramente “tecnica” avanzata per giustificare il lavoro di molti altri: sappiamo che egli era stato sempre ben consapevole delle implicazioni politiche del lavoro “tecnico” del giurista. Dovrebbe, quindi, valere un’altra spiegazione: la partecipazione di alcuni giuristi fu il modo attraverso il quale si riuscì a spuntare (o a limare) gli aculei ideologici della più ambiziosa opera legislativa concepita dal regime fascista. Il C. considerò appunto il lavoro di codificazione come un compimento, sia pure parziale, del disegno chiovendiano: e si sforzò di dimostrarlo nel primo volume delle Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice (Padova 1941), anche cm una copia di riferimenti alla dottrina corporativa che oggi riescono, a dir poco, fastidiosi. Ad ogni modo, se allo stato attuale delle ricerche la spiegazione fondata sulla volontà di resistenza all’interno del “sistema” può ancora apparire plausibile, non lo è invece quella che, attribuendo alla partecipazione del C. un significato diverso da quella di altri accademici, la intende come una sorta di resa della scienza “ufficiale” del fascismo, incapace di portare da sola a compimento l’impresa di riforma del codice e quindi costretta a ricorrere agli uffici di chi aveva fino ad allora ignorato o isolato.
Il precipitare degli avvenimenti in Europa aveva assai acuito la già vivissima sensibilità del C. per i problemi della legalità e della certezza del diritto. E ciò appare chiaramente non tanto dallo scritto ben noto su La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina (1942; in Studi, V, pp. 91-111), recensione entusiasta di uno scritto di Flavio Lopez de Onate; quanto piuttosto dalle rassegne sulle tendenze del diritto processuale tedesco, pubblicate a partire dal 1938 sulla Rivista di diritto processuale civile.
Questo guardare polemicamente alle vicende della Germania nazista non fu solo del C.: romanisti, civilisti, penalisti denunciarono la progressiva perversione di quell’ordinamento, con toni tanto più vivaci quanto più cresceva il disagio di dover accettare meno violente, ma non meno insidiose, rotture della legalità in casa nostra. A rileggerli oggi, quegli scritti sono un po’ lo specchio della cattiva coscienza di molti tra i migliori giuristi italiani di quegli anni (oppure estreme e ingenue “lettere persiane”?). Comunque, il C. seppe cogliere in modo netto, a differenza di altri, le ragioni vere e reali del disfacimento della giustizia nella Germania nazista: non le debolezze di un ceto di giuristi traviato da cattive dottrine, ma la brutale trasformazione della magistratura in una polizia politica al servizio del regime.
Nel 1941 il C. aderì al movimento di “Giustizia e libertà” e nel 1942 fu tra i fondatori del Partito d’azione. All’indomani della caduta del fascismo, il 26 luglio 1943, divenne rettore dell’università di Firenze e lo fu fino all’8 settembre, quando, colpito da mandato di cattura, fu costretto a rifugiarsi in Umbria. Liberata Firenze, riassunse le funzioni di rettore, che mantenne fino al 1947.
Si apre così il periodo più intenso e appassionato della sua vita, al quale si era spiritualmente preparato rimeditando Beccaria e Ruffini, per le cui riedizioni (rispettivamente del 1945 e del 1946) detterà ispirate introduzioni. La pubblicazione, nel 1944, della seconda parte delle Istituzioni segna il congedo dal genere letterario accademico, mentre nasce lo “scrittore politico”. In questa nuova attività, che copre gli anni dal 1944 al 1956 e i cui contributi sono ora raccolti nei tre volumi degli Scritti e discorsi politici (Firenze 1966), Norberto Bobbio ha lucidamente distinto “quattro tempi che corrispondono a quattro momenti diversi, abbastanza bene caratterizzati, di una battaglia politica senza soste”.
Il primo tempo va dalla liberazione di Firenze (agosto 1944) alla proclamazione della Repubblica (giugno 1946). Il C. lo vive come consultore nazionale, battendosi per la tesi della continuità costituzionale dello Stato italiano e per il primato del governo dei Comitati di liberazione nazionale, prima; e poi sostenendo la tesi della piena sovranità dell’Assemblea costituente. Quando si profilò l’intenzione di Umberto di Savoia di ricorrere al referendum istituzionale, il C. pronunciò l’8 marzo 1946, a nome del Partito d’azione, un vivacissimo discorso di opposizione. Nel 1945, intanto, aveva fondato la rivista IlPonte, che rappresenterà lo strumento più incisivo della sua battaglia civile.
Eletto alla Costituente in rappresentanza del Partito d’azione, il C. vive il secondo, febbrile tempo della sua nuova esperienza politica, partecipando attivamente ai lavori di preparazione della Costituzione come membro della Commissione dei 75 e come relatore sull’ordinamento della magistratura e sulla Corte costituzionale.
Nella sua attività di costituente si intrecciano motivi diversi: dalla speranza in un nuovo ordinamento dei “diritti sociali”, che riprendeva motivi già ben presenti nella sua opera e che era stata rafforzata proprio curando la introduzione della ristampa dei Diritti di libertà di F. Ruffini; alla preoccupazione per la stabilità dell’esecutivo; all’azione decisa per l’indipendenza della magistratura e per l’introduzione della Corte costituzionale (l’istituzione a cui più si sarebbe riferito negli ultimi anni della sua vita, ma che in sede costituente volle circoscritta da una rigida disciplina, come dimostra la sua opposizione a norme che prevedessero la possibilità di un ricorso diretto dei cittadini alla Corte); alla opposizione per la inclusione dei Patti lateranensi nella Costituzione, manifestata con un duro discorso in Assemblea il 20 marzo 1947.
Sciolto il Partito d’azione, entrò a far parte del gruppo Azione socialista Giustizia e Libertà, poi confluito nell’Unione dei socialisti insieme con un gruppo guidato da I. Silone. Per le elezioni del 1948 venne formato con il P.S.L.I. un raggruppamento elettorale, Unità socialista, nelle cui liste il C. fu eletto alla Camera dei deputati. In questo terzo tempo cadono le speranze del C., che denuncia la nascita di un nuovo regime e propone il tema della “Costituzione inattuata”.
I momenti più significativi della sua azione parlamentare sono il voto contro il Patto atlantico e la battaglia contro la legge elettorale maggioritaria del 1953, posizioni assunte anche in contrasto con gli orientamenti del proprio partito. Reagendo a prassi ritenute intollerabili dell’azione di governo, accentua la sua visione morale della lotta politica, che lo induce a considerare con insofferenza sempre maggiore le regole del gioco proposte dai partiti ufficiali.
È prima nel P.S.U., nato dalla confluenza della Unione dei socialisti e dei gruppi di Romita e Mondolfo; poi, nel 1951, è nel P.S.D.I., il nuovo partito sorto dalla fusione del P.S.L.I. e del P.S.U. In contrasto con il P.S.D.I., per la legge elettorale, esce dal partito e costituisce il raggruppamento di Unità popolare insieme con Parri, Jemolo e altri. Alle elezioni del 7 giugno 1953, nessuno dei candidati di Unità popolare fu eletto, ma il numero di voti raccolti dalla lista contribuì a impedire il funzionamento del meccanismo elettorale della legge maggioritaria.
Questo successo restituì una certa fiducia al C., che, proseguendo nella sua battaglia per l’attuazione della Costituzione, vide un buon auspicio nella realizzazione, nel 1955, della Corte costituzionale.
E il C. partecipò, come avvocato, alla prima udienza della Corte, sostenendo la tesi, poi accolta, della sindacabilità delle leggi anteriori alla entrata in vigore della Costituzione: uno degli ultimi atti di un’attività forense che aveva sposato le ragioni della difesa in tutti i maggiori processi in cui erano state in questione le libertà civili, da quello contro D. Dolci a quello ai giornalisti Renzi e Aristarco.
L’attività di politico e di avvocato fu sempre sostenuta da una intensissima attività di scrittore. Tra le varie imprese per tal via portate a compimento debbono essere ricordate almeno il Commentario sistematico della Costituzione (2 voll., Firenze 1950), realizzato assieme ad Alessandro Levi e a una nutrita schiera di collaboratori, opera che rimane anche come una curiosa testimonianza dell’arretratezza della cultura giuridica italiana, visibile nel contrasto tra le aperture contenute nell’introduzione del C. e le ottuse resistenze di alcuni commentatori; e la raccolta di conferenze pubbl. con il titolo Processo e democrazia (Firenze 1954). La fede nella Costituzione, di cui pure aveva così lucidamente visto i limiti quando lavorava per essa nell’Assemblea costituente, gli fece forse talvolta velo, e lo indusse a guardare all’attuazione costituzionale come a un rimedio che avrebbe guarito tutti i mali d’Italia. Egli però ben sapeva che non bastavano le leggi ad attuare la Costituzione, perché era necessario ritrovare il diverso spirito che, nel 1944, lo aveva convinto che l’Italia fosse entrata in un periodo rivoluzionario. A celebrare quel diverso spirito, perché non si smarrisse il ricordo della lotta contro nazisti e fascisti in cui era nato, il C. si dedicò con rievocazioni di fatti ed epigrafi, poi raccolte nel volume Uomini e città della Resistenza (Bari 1955), nel quale con alta retorica vuole essere il vate della nuova Italia nata dalle lotte per la Liberazione.